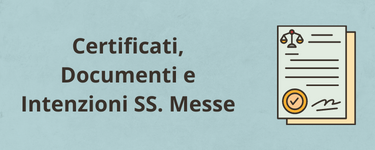Pontenure e le epidemie: la prima epidemia di colera (1836)
di Redazione Sito · Pubblicato · Aggiornato
Pontenure e le epidemie: la prima epidemia di colera (1836)
Peste e colera: due morbi che, per secoli, hanno fatto tremare l’umanità. Della peste, che arrivò nella nostra Parrocchia nell’estate del 1630, abbiamo già parlato in un precedente articolo, questa volta ci concentreremo invece sul colera e in particolare sulla prima epidemia che colpì il nostro paese.
Il colera (Cholera morbus) è una malattia infettiva, spesso mortale, conosciuta fin dai tempi di Ippocrate, provocata dal vibrione colerico o bacillo virgola. In Europa il colera rimase praticamente sconosciuto fino all’inizio dell’Ottocento, quando con drammatica violenza si abbatté sulle popolazioni del Vecchio Continente proveniente dall'India (regione del delta del Gange), meritando il soprannome di "morbo asiatico". La sua comparsa fu così improvvisa e minacciosa da caratterizzare la storia sanitaria dell’Ottocento, non tanto e non solo per il numero di vittime mietuto, assai inferiore a quello delle grandi epidemie di peste, quanto per il panico collettivo causato. Tornarono ad affacciarsi, in pieno XIX secolo, l’antico terrore della peste e la paura incontrollabile del male oscuro, misterioso, invisibile. Alla sua comparsa i medici ignoravano, infatti, sia come si contraesse, sia come agisse la malattia. Nel 1854 il nostro connazionale Filippo Pacini individuò al microscopio il vibrione del colera. La scoperta passò però inosservata, fino a quando nel 1883 il medico tedesco Robert Kock identificò a sua volta il germe e riuscì anche a studiarne il comportamento, permettendo allo spagnolo Ferran di mettere a punto, l’anno successivo, il vaccino anticolerico.
Dopo essersi sviluppata nel Bengala, l’epidemia raggiunse la Russia nel 1829, quindi i Paesi baltici. Nel 1831 si diffuse poi in Inghilterra e da lì nel 1832 arrivò in Francia: nella sola Parigi, nel giro di sei mesi, morirono oltre 18 mila persone. Il colera penetrò in Italia dalla Francia meridionale nel 1835 e da allora vi infierì con ben otto successive ondate epidemiche, fino al 1910-1911, mietendo un gran numero di vittime. Già nel 1835 i vari Stati in cui era allora suddivisa la nostra penisola adottarono severe misure di prevenzione, ma queste e altre misure risultarono ahinoi vane e il colera si diffuse rapidamente in tutta Italia.
La prima epidemia di colera si abbatté sulla città di Piacenza tra il 20 giugno ed il 20 settembre 1836, provocando la morte di 545 persone, su una popolazione di 29.330 abitanti, in fondo poca cosa, come si ricordava in precedenza, rispetto alla mortalità causata dalla peste di tre secoli prima. Il 14 giugno di quell’anno era morto il vescovo Ludovico Loschi, che per dodici anni aveva retto la nostra Diocesi. Ma già il giorno dopo, al cordoglio per la morte del pastore, si erano unite le prime preoccupazioni per le allarmanti notizie dei primi casi del cholera morbus. Qualcuno diceva che le avvisaglie dell'epidemia si erano già avute a Parma; qualcun altro assicurava che, nella zona di Monticelli, l'epidemia si era diffusa tra i montanari (probabilmente i "taglialegna") che lavoravano lungo le rive del Po. Il primo caso mortale a Piacenza si verificava il 21 giugno, all'ospedale civile, dove cessava di vivere Giacomo Gastaldi, originario di Pomaro (Piozzano), che era appena tornato dalla Lombardia dove si era recato per lavoro. Da quel momento scoppiò l'epidemia che, in un primo tempo, aveva lasciato scettici i piacentini, disposti ad accusare i medici che, secondo loro, per rendersi importanti avevano inventato una malattia che in realtà non esisteva, ma che invero si diffuse rapidamente tra le fatiscenti casupole del quartiere di Cantarana, nella zona di Sannazzaro e di San Bartolomeo. Presso la chiesa di Sant'Agostino veniva predisposto un lazzaretto per accogliere i malati ed isolarli, anche se molti dei familiari si opponevano al trasporto dei loro cari e cercavano addirittura di nascondere l'esistenza degli ammalati, mentre i medici fecero tutto ciò che era in loro potere per contrastare il morbo, curato allora con l’utilizzo di solfato di chinino in infusione nel vino, di oppio e laudano oltre a fregagioni con ammoniaca, canfora ed olio di trementina.
Un decreto del 25 luglio del Governo ducale (in quei giorni la duchessa Maria Luigia si era assentata dal Ducato dopo aver fatto fondere i metalli preziosi che avevano ornato la culla di suo figlio, il «re di Roma», per ricavarne denaro da destinare alle cure preventive contro l'epidemia) ristabiliva nei Ducati la Compagnia di Gesù. Venivano fatti sospendere dappertutto fiere e mercati, si proibiva ai mietitori del contado di entrare in città, si ritirava l'acquasanta dalle pile delle chiese, veniva interrotto il servizio postale e chiuse le scuole. Un cronista del tempo descrive i lugubri carri funebri che percorrevano la città, i medici e portantini indossanti delle vestaglie nere con buchi per gli occhi e per la bocca, le funzioni religiose interrotte, frati e monache che prendevano il posto degli infermieri (che pare si fossero distinti per la loro rapacità) nell'assistenza ai malati, la concentrazione dei reclusi nelle carceri di San Sisto, la disinfezione del Macello e degli uffici pubblici con suffumigi al cloruro di calce. «Sui primi di settembre il cholera diminuisce. Si ripone l’acquasanta nelle pile delle chiese. Si cantano Tedeum di ringraziamento. Insomma si è liberi dall’epidemia. E nel novembre, allorché i Gesuiti riaprono le scuole di San Pietro, la città è monda dal tetro flagello». I morti ormai giacevano nella terra e i vivi si davano pace.
Anche il nostro paese fu duramente colpito da questa prima ondata epidemica. Il ventunesimo volume del nostro registro dei Defunti segnala infatti il 26 luglio 1836 il decesso di Biagio Tedaschi, di circa 40 anni, marito di Maria Romani (che morirà a sua volta qualche giorno dopo), colpito da «mortalissimo morbo ut ajunt colera morbus». Quel medesimo giorno morivano, sempre a causa del colera, anche Carlo Rossi e Francesca Bertonazzi, moglie di Francesco Caccialanza. Si ripetono così, sfogliando con attenzione quelle pagine ormai ingiallite dal tempo, le annotazioni di morte, tutte attribuite al «pestilentissimo, letalissimo, fatalissimo colera morbus». Non mancano però alcuni spunti più interessanti, più precisi e quasi scientifici come il seguente, qui tradotto in italiano: «questo tipo di morbo viene trasmesso agli altri con grande facilità e viene contratto sia dal contatto sia attraverso l’avvelenamento dell’aria». Altri sei decessi sarebbero seguiti entro la fine del mese di luglio; ben ventisette persone moriranno invece nel mese di agosto. Alcune erano originarie di altre parrocchie della città e del contado, ma si spensero presso un ospedale per colerosi allestito in località Menarolo, a poca distanza dal borgo. Un’altra mezza dozzina di decessi seguirono nel mese di settembre. L’ultima vittima si registrò il 30 ottobre 1836. A firmare gli atti di morte furono dapprima l’arciprete Giacomo Rossi, che morì a sua volta (anche se non di colera) il 5 ottobre, poi i curati Giacomo Salini e Angelo Saccardi che lo sostituirono nell’amministrazione della Parrocchia. Quasi tutte le vittime del morbo, ben quarantacinque, trovarono sepoltura presso il cimitero della nostra Parrocchia che in quegli anni sorgeva nei pressi della stazione ferroviaria. Da notare che quasi tutti coloro che morirono poterono ricevere l’Estrema Unzione e il Viatico, a segnalare l’instancabile opera di assistenza dei sacerdoti a favore degli infermi.
Come si è visto anche la nostra Parrocchia ebbe parecchio a soffrire a causa del morbo, non solo per i tanti lutti, ma anche dal punto di vista finanziario: dovette infatti contribuire all’imposta straordinaria, decretata dalla duchessa Maria Luigia a favore degli Ospizi Civili di Parma, per una somma pari a 56,44 lire del tempo, che andarono inevitabilmente a gravare sul già scarso bilancio dell’Opera parrocchiale, mentre in quei mesi si incrementò considerevolmente il consumo di cera, causato dalla necessità di somministrare il sacramento del Viatico ai morenti. Tutto ciò si evince dalle numerose note e lamentele lasciate dagli amministratori sui libri contabili del tempo ancora conservati presso il nostro Archivio parrocchiale. Di seguito le pagine del ventesimo tomo del Libro dei morti su cui sono riportati i decessi avvenuti a causa del colera.
Questo slideshow richiede JavaScript.