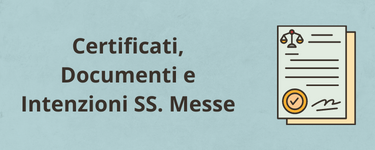9 Febbraio 1945 – Il sacrificio di don Giuseppe Borea
di Redazione Sito · Pubblicato · Aggiornato
9 Febbraio 1945 - Il sacrificio di don Giuseppe Borea

Il cappellano partigiano don Giuseppe Borea, splendida figura di sacerdote, fucilato dai fascisti il 9 febbraio 1945 presso il cimitero urbano di Piacenza. Anche il nostro Comune gli ha dedicato una via nella frazione di Valconasso.
La nostra vicenda ha come protagonista un sacerdote come tanti, un giovane prete di montagna che negli anni Quaranta del secolo scorso svolgeva il suo ministero ad Obolo, una frazione di Gropparello, poche case a 900 metri d’altezza. Il grosso dell’abitato sorge un poco defilato, alle pendici del monte omonimo, poi sulla strada provinciale si scorgono la vecchia osteria, qualche abitazione, e infine una bella chiesetta dedicata a San Bartolomeo Apostolo con accanto la canonica.
È proprio in questa canonica che per quasi otto anni visse don Giuseppe Borea, nominato rettore della parrocchia nell’estate del 1937. Don Giuseppe nasce il 4 luglio 1910 a Piacenza, in via Cavallotti (odierna via Roma), il primo dei cinque figli frutto dell’unione tra Paolo, che aveva un negozio d’arte in città, e Isoletta Scala, maestra elementare. Avviato al sacerdozio dallo zio, mons. Riccardo Sala, dopo aver frequentato i Seminari di Bedonia e di Fidenza, completa i suoi studi presso il Seminario Urbano di Piacenza. Il 28 marzo 1936 è consacrato sacerdote nel duomo di Piacenza, e il giorno successivo comincia il suo ministero nella parrocchia di Santa Maria in Gariverto, dove celebra la sua prima messa.
Dopo essere stato per breve tempo curato a Morfasso e Bardi, arriva per lui dalla Curia la proposta di reggere la chiesa di Obolo. Don Giuseppe accetta con entusiasmo, malgrado la contrarietà della famiglia. La parrocchia è assai povera, la chiesa stessa è trascurata, ma don Giuseppe con il suo genuino entusiasmo e la volontà di darsi da fare non si lascia certo sgomentare dalle tante difficoltà. Inizia così la sua missione di pastore buono e provvido, fatta di opere concrete e di apostolato a favore dei parrocchiani. Non solo inizia ad abbellire la chiesa (dotandola di un nuovo altare maggiore con il relativo tabernacolo, rimettendo a nuovo la cappella della Madonna del Buon Consiglio e acquistando una nuova statua del patrono San Bartolomeo), ma negli anni farà sistemare il vecchio cimitero e restaurare la canonica, il tutto grazie alle offerte dei parrocchiani e mettendo a coltura alcuni appezzamenti incolti del Beneficio parrocchiale. Giovane e pieno di energie, tanto s’impegna che riesce persino nell’impresa di far arrivare in quel luogo sperduto la corrente elettrica, quasi un lusso per quei tempi, partecipando in prima persona anche ai lavori di scavo per la posa della linea.
A ispirarlo in tutta la sua azione è la figura del buon Pastore: "Figliuoli carissimi, mio gaudio, mia corona (...) eccomi in mezzo a voi e perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza (...) che io non riceva grazia maggiore di quella di udire che i miei figli camminano nella verità", egli scrive nel ricordino distribuito il giorno solenne dell’ingresso in parrocchia. A tale programma don Giuseppe si attiene con fedeltà, promuovendo instancabile, accanto alle opere, anche l'elevazione spirituale delle anime a lui affidate, suprema missione di ogni buon sacerdote. Incrementa la devozione verso la Madonna del Buon Consiglio, da lui definita "la Castellana della Val Chero", infonde nuovo vigore alle associazioni cattoliche e alla Compagnia del Santissimo Sacramento, fonda ex novo l’Azione Cattolica colle sue varie ramificazioni, promuove il solenne rito delle Quarantore, insegna con scrupolo il catechismo ai fanciulli, mette insieme un coro di notevole capacità, organizza conferenze e spettacoli di arte varia nel piccolo teatrino della parrocchia.
Lo circonda unanime la stima e l’affetto dei parrocchiani, dai quali riesce fin da subito a farsi volere bene. Ancora molti anni dopo la sua tragica morte, essi lo ricorderanno come un prete eccezionale, sempre disponibile, con grandi capacità di organizzatore, che non si risparmiava e non sentiva la fatica. Non mancano però i primi screzi con il potere politico: lo zelo del suo apostolato e il grande affetto della sua gente non possono essere graditi a un regime totalitario che, specie negli ultimi anni di vita, vorrebbe ricondurre a sé e al partito ogni cosa, che pretende di fascistizzare ogni aspetto della vita pubblica. D’altro canto don Giuseppe si dimostra un geloso custode delle libertà, religiose e civiche, della sua povera gente, e spesso si diverte a scombussolare i programmi, le parate e i festini organizzati dal Partito fascista.
Purtroppo, il triste turbine della guerra incombe anche sulla nostra cara Italia e sul mondo intero, nubi oscure si addensano scatenate dall’odio e dalla follia degli uomini. All’inizio le vicende dell’immane conflitto non coinvolgono troppo Obolo e la sua gente, che continua la solita esistenza di tutti i giorni: gli accadimenti sembrano echi di fatti lontanissimi e le notizie che giungono dai vari fronti sono frammentarie e spesso contraddittorie. Nell’estate del 1942 don Giuseppe si propone come cappellano militare al comando del distretto di Piacenza, pronto a partire subito, in qualsiasi posto, per aiutare e servire i soldati al fronte, ma la cosa non ha seguito per la contrarietà del vescovo di Piacenza, mons. Menzani.
Tutto cambia però con l’8 settembre del 1943: non si tratta più di raggiungere le desolate steppe delle Russia o le assolate distese della Libia, con i tragici fatti dell’Armistizio, la resa dell’Italia, l’occupazione tedesca e la nascita della Repubblica Sociale, il conflitto raggiunge anche Obolo e i suoi splendidi monti. Nella stragrande maggioranza i giovani rifiutano di arruolarsi, non rispondono ai bandi di leva emanati dal governo fantoccio alla cui guida è stato installato il Duce, ma si danno piuttosto alla macchia e ben presto prendono le armi per resistere all’invasore tedesco e ai suoi scherani. Di colpo la montagna si popola di un’umanità varia e di tante razze e lingue, come mai era capitato in secoli di storia: militari italiani sbandati, prigionieri angloamericani, slavi o russi fuggiti dai campi di prigionia, giovani disertori e renitenti alla leva.
Di fronte a questo immane dramma, a differenza di altri sacerdoti, don Giuseppe non si rinchiude nella sua chiesa ma decide di continuare la sua missione di pastore, operando con spirito di fratellanza e uguale fervore tra le due parti in lotta: la parola di Dio e il conforto dei sacramenti sono per tutti, sostiene, spesso non indossa la tonaca ma vestiti da montanaro, nessuno mai lo vede mai armato e sulla camicia ha cucita una vistosa croce rossa, simbolo e grado dei cappellani militari. Don Giuseppe spalanca le porte della canonica, ospita feriti e fuggiaschi, si fa amico e confidente di tutti, condivide con i bisognosi lo scarso cibo disponibile e col tempo diviene cappellano militare dei partigiani (giugno 1944), col compito di provvedere all'assistenza spirituale dei patrioti della "Divisione Val D’Arda ".
È don Giuseppe che si occupa dei tre giovanissimi partigiani uccisi nel sonno dai repubblichini di Salò in località Monte Lana, nella zona di Prato Barbieri, i primi caduti della Resistenza piacentina uccisi a tradimento nel sonno. Nonostante i divieti espressamente emanati, porta le loro salme al cimitero di Obolo, le compone in pace e ne celebra le esequie. È di nuovo lui che si precipita ai Guselli di Morfasso, dove il 4 dicembre 1944 un’imboscata tesa a una colonna partigiana dai militari della Divisione Turkestan culmina con l'uccisione di venticinque patrioti e con la cattura di altri dieci. Don Giuseppe si reca al preventorio di Bettola per confortare e distribuire immaginette sacre ai partigiani feriti, ma uguale fervore dimostra al Colombello o a Groppo Ducale, dove i partigiani tenevano i prigionieri: a tutti offre i sacramenti, una parola di conforto. Protetto dalla sua tonaca, che lo qualifica come ministro di Dio, spesso don Giuseppe si offre spontaneamente come intermediario per lo scambio dei prigionieri, fa da scudo alle colonne e da garante tra le parti quando si stringe un patto.
A causa di una delazione, don Giuseppe viene arrestato il 30 gennaio 1945, mentre la guerra è quasi agli sgoccioli, gli Alleati si preparano alla grande offensiva primaverile che sfonderà la Linea Gotica. Egli sta ritornando a piedi da Morfasso, dove si era recato per ragioni di ministero, quando arriva a Prato Barbieri una pattuglia di militi della Guardia Nazionale Repubblicana, giunti appositamente da Piacenza con l’ordine di catturare il cappellano don Borea. La figlia del proprietario della locale osteria, signora Giuseppina Mutti, lo raggiunge per la via e lo implora e lo scongiura di scappare lontano, di non tornare in canonica perchè i fascisti lo aspettano per arrestarlo, ella li ha uditi. La giovane tira con forza la veste talare di don Giuseppe, che vuole proseguire per la sua strada. Non si sente in pericolo, non ha fatto nulla di male, protesta, e perciò non ha nulla da temere: si consegna spontaneamente ai suoi carnefici, forte della sua innocenza e serenità.
A firmare l’ordine che chiede il suo arresto è un capitano della Milizia fascista, ma sicuramente non è solo lui a decidere. È viva e condivisa, in quel tragico inverno del 1945, nei quadri dirigenti la necessità di dare una lezione al clero piacentino, colpendo con una severità che annulla ogni giustizia uno dei suoi esponenti. La sentenza, infatti, è già scritta ancora prima dell’arresto. Quale giustizia si sarebbe potuta trovare del resto davanti a un tribunale che si rifiuta di ascoltare i testi della difesa, rimprovera il difensore per eccesso di zelo, ignora le testimonianze degli stessi militari repubblichini, desiderosi di affermare che don Giuseppe li ha sempre trattati con umanità. Il quotidiano "La Scure" lo chiama "don Boia", denigrandolo e deridendolo. Le accuse che gli vengono rivolte sono gravissime e infamanti, del tutto infondate. Non c’è solo quella di "aver indossato la divisa da partigiano e avere militato contro la nazione al soldo dello straniero", ma anche di "aver infierito con tre colpi di pistola contro un milite prigioniero dei partigiani che sarebbe stato fucilato davanti al preventorio Rocco Chiapponi di Bettola". Ancora, il capo d'imputazione più infamante fra tutti: "fatti di immoralità" nei confronti della sorella che, lei stessa, avrebbe denunciato in questura mettendoli nero su bianco.
In molti si mobilitano con coraggio per salvare la vita di questo eroico sacerdote: la sorella stessa, che nega con risolutezza di aver mai scritto nulla contro il fratello, lo zio, mons. Sala, il vicario generale della Diocesi, mons. Italo Sgorbati, mons. Francesco Castagnetti, due bravi avvocati piacentini che si dicono disposti a difenderlo, gli stessi militi repubblichini che lo hanno conosciuto durante la prigionia. Tutti gli sforzi di costoro si rivelano però vani, nulla possono contro il muro insormontabile del tempo, dell’invidia e dell’odio. La difesa di don Giuseppe è affidata a un avvocato d'ufficio, il maggiore della Milizia Ambrogio Ginanneschi, "un fascista come tutti gli altri, ma stimato per la sua rettitudine ed onestà", che tenta ogni strada per salvare il giovane sacerdote. La sua difesa è così valida e appassionata da costargli, in seguito, l’espulsione dal Partito. Mentre il suo avvocato combatte in aula una battaglia perduta in partenza, don Giuseppe, rinchiuso nelle carceri di Piacenza, passa le sue giornate in ginocchio, raccolto in preghiera sul pagliericcio della sua cella, e non cessa di confortare gli altri prigionieri.
"Il mio posto era là! E là ero rimasto", così don Giuseppe risponde ai giudici che gli elencano i capi di imputazione, rivendicando con orgoglio di non aver disertato, di non aver abbandonato le anime che gli erano state affidate, anche quando la sua parrocchia era caduta in mano ai "banditi", così venivano definiti i partigiani. Si difende con dignità non disgiunta da fermezza: ammette candidamente il sostegno da lui offerto alla causa della Resistenza, conferma di aver indossato a volte la divisa partigiana con il distintivo del grado, ma nega con fermezza ogni altra accusa di brutalità o immoralità. Tutto è vano, il 6 febbraio ha inizio il processo e la sera stessa viene emessa la sentenza: don Giuseppe è ritenuto colpevole e viene condannato a morte per fucilazione. Il Vicario generale Sgorbati inoltra la richiesta di grazia alle autorità di Salò, ma il generale Raffaele De Logu, capo del comando territoriale di Alessandria, la respinge senza pensarci, rifiutandosi anche di sottoporla al Duce, per evitare che un eventuale gesto di benevolenza annulli l'esecuzione, che deve per l’appunto sortire il suo effetto di monito esemplare presso il clero e la popolazione.
La sentenza è ormai emessa per il tribunale degli uomini: non è mai difficile condannare un innocente, il Vangelo ce lo insegna. Gli uomini disposti a mentire si trovano volentieri, le prove se occorre si falsificano, le sentenze si aggiustano e basta poco per convincere un giudice ingiusto, ma Don Giuseppe è ormai oltre a tutte queste miserie umane, contempla già il volto misericordioso del Signore che lo aveva chiamato nel numero dei suoi ministri e forse ne ricorda le parole: "Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi" (Giovanni 15,20). Gli è concessa, tra tante vessazioni e ingiustizie, l’ultima gioia: quella di rivedere sua madre. I suoi occhi diventano raggianti quando la vede entrare nella cella. È un momento intimo, intenso e commovente. Sono le quattro del mattino di un freddo e nevoso 9 febbraio, un venerdì, il giorno della Croce.
"Tutto è compiuto", quel giorno come quell’altro Venerdì, sul Calvario. Don Giuseppe è pronto: gli hanno impedito di celebrare per l’ultima volta la messa, ma riceve il Viatico, si confessa col cappellano. Così scrive nel suo testamento: "Lascio alla mia carissima parrocchia il mio cuore. L’ho amata! Se qualche volta non avessi compiuto il mio dovere di parroco ne domando sinceramente perdono a tutti. Mi raccomando al suffragio di tutti e in modo particolare a quello dei miei Parrocchiani. (…) Desidero come estremo conforto e come onore di riposare nel cimitero della mia Parrocchia dove ho deposto tante vittime. (…) E passerò il mio Paradiso a compiere ancora quel bene che, per la vita troppo giovane che mi viene tolta, non ho potuto fare sulla terra. (…) Addio, arrivederci in paradiso! Viva Gesù, Viva Maria!".
È il tardo pomeriggio del 9 febbraio 1945 quando don Giuseppe viene condotto presso il recinto del cimitero di Piacenza per l'esecuzione della sentenza. Rifiuta la sedia e la benda, guarda negli occhi i militi della Guarda Nazionale Repubblicana, li benedice per l’ultima volta e pronuncia il suo estremo addio, perdonando i suoi carnefici, come aveva fatto il Maestro: "Muoio innocente. Perdono di cuore a coloro che mi hanno fatto tanto male e anche a voi che dovete sparare. Spero che il mio sacrificio giovi alla patria nostra. Se stasera sarò in Paradiso, pregherò per tutti e perché Iddio faccia sorgere giorni più belli e sereni per l’Italia". Il plotone di esecuzione punta il mitra contro di lui, che stringe al petto il crocifisso e cade come un novello martire, colpito da otto pallottole. Viene finito con un colpo alla nuca. Non aveva ancora compiuto 35 anni. Nel 1977 gli è stata conferita la Medaglia d'argento al Valor Militare alla memoria.
Da 77 anni, in quel luogo dell’alta Val Chero, risuona ancora la frase di Gesù: "Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore" (Giovanni 10,11). Sono passati ormai molti anni da quei giorni lontani, ma, a Obolo, in quelle nostre montagne sempre più spopolate, non sembra essere cambiato nulla. Sul prato davanti alla chiesetta di San Bartolomeo un cartello informa il viaggiatore di quei fatti lontani e sul cartello spicca una foto di don Giuseppe, che ci osserva con il suo viso da bambino: è certamente uno di quei giusti che erediteranno il Regno.
Redazione sito parrocchiale